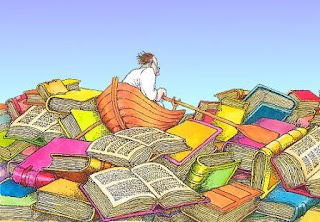Appena nato, ogni essere umano si percepisce come un'entità indifferenziata dalla persona che di lui amorevolmente si prende cura; nei primissimi mesi di vita (si parla infatti di diade madre-bambino) egli non ha una esatta percezione del Sè come entità separata dalla madre. Il seno che lo allatta sarà considerato alla stregua di un'estensione di sè piuttosto che facente parte dell' Altro-da-sè; potremmo dire che vi è una sovrapposizione tra Soggetto e Oggetto.
Mano a mano che egli procede nello sviluppo, passando attraverso specifiche e riconoscibili fasi di separazione dalla madre e di individuazione del Sè, verrà creandosi un sentimento di identità, frutto della interrelazione tra mondo soggettivo e mondo oggettivo (fase della separazione-individuazione).
Dal sorriso, come precursore della capacità di differenziazione Sè - Altro da sè, passando per la crisi dell'estraneo dell'ottavo mese, arriverà dunque intorno ai due anni fino al riconoscimento di sè allo specchio.
E' questo un momento cruciale, il momento in cui “il bambino nello specchio” corrisponde al “Sè”, e per l'essere umano comincia la fase del “mi riconosco dunque sono”.
Poiché nell'Altro, in cui come in uno specchio ci si riconosce , si trova un'oggettivazione di sè, e il primo“specchio” è costituito dallo sguardo materno capace di rimandare l'immagine di chi viene “guardato”, da questo momento in avanti è importante che il bambino possa già riconoscersi come relativamente Bello, Bravo e Buono.
Soltanto così potrà crescere sano e soddisfatto e forte abbastanza per affrontare il proprio destino nel mondo (inteso come dàimon), con la necessaria sana aggressività intesa (etimologicamente dal latino ad - gredior: andare - verso, e non semanticamente come diminuzione del potere dell'altro ) come forza propulsiva che gli consenta di mettersi in gioco attivamente, proteggendosi dal dover subire passivamente e sapendosi trarre fuori dalle difficoltà realizzando al meglio le proprie qualità: non vittima, dunque, ma neanche narcisisticamente dominante come chi si imponga con protervia "über alles " ritenendosi migliore a priori.
Il saper rilevare assonanze e discrepanze tra l'immagine idealizzata e statica di noi stessi (la stessa che Narciso passava il tempo a rimirare nelle acque ferme dello stagno) e quella che occhi altrui di volta in volta ci rimandano in maniera diversa e in qualche modo cangiante, ci consente di continuo opportune correzioni necessarie all'adattamento; ricordo qui che l'intelligenza cognitiva come quella affettivo-emotiva anch'essa in perenne sviluppo, altra funzione non ha se non quella appunto di promuovere l'adattamento. In un mondo che è in perenne mutamento ove, sempre, inevitabilmente, "panta rei ".
E' dunque importante che l'immagine di sè che va strutturandosi sia sufficientemente positiva, ma anche adeguata a “ciò che davvero è”, senza tracotanza (hybris) e secondo misura (katà metron).
E' notorio che chi si stima come forte sarà resistente fino a sbaragliare i nemici e a superare le difficoltà, chi si stima coraggioso saprà affrontare le asperità anche facendo i conti con la paura, chi si stima bello saprà più facilmente rendersi piacevole e gradito.
Una positiva immagine di sè, diremo così "di base", sarà determinante per far fronte al meglio alle avversità, e renderà meno esposti alla paralisi della paura di fronte all'insuccesso come alla reiterata frustrazione o al dolore. Proteggerà a maggior ragione sia contro l'angoscia esistenziale (che diversamente dalla paura non identifica l'oggetto che la scatena e rifugge dal nulla che ci precede come da quello che ci attende), sia contro la disperazione (frutto della perdita del senso nell'agire quotidiano date l'ineluttabile precarietà della nostra esistenza e la contemporanea non accettazione di questo limite).
Che cosa dunque necessita al cucciolo dell'uomo per potersi stimare sufficientemente piacevole, benvoluto e meritevole, in misura equilibrata?
La percezione di sè come individuo apprezzato e apprezzabile comincia, secondo me, con la possibilità di riconoscersi, nello sguardo indulgente e soddisfatto della figura materna nei confronti della quale si sviluppa l'attaccamento, come Bello (“ogni scarrafone è bello a mamma soia...”).
E' forse ipotizzabile che la prima valutazione del bambino, fatta attraverso lo sguardo genitoriale, sia di tipo estetico; d'altronde non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace...
Tale percezione è veicolata primariamente dallo sguardo indulgente, carezzevole e soddisfatto della madre fin da quando ella lo allatta e se ne prende cura manipolandolo, vezzeggiandolo e cullandolo nell'abbraccio.
Lo sguardo materno è il primo specchio in cui il cucciolo “vede se stesso”, è il primo strumento riflettente capace di rimandargli un'immagine di sè medesimo. E' una sorta di veicolo per l' imprinting dell'autostima.
In seguito, lo sguardo, le parole e i modi materni, semprechè bonari e soddisfatti, potranno convincere il bambino circa la propria possibilità di corrispondere alla soddisfazione materna .
E' allora che egli si percepisce buono ( è “buono “perchè sorride responsivo, perchè mangia e dorme regolarmente, perchè gode nell'essere cambiato e lavato...).
Se è possibile riconoscere un benessere emotivo reciproco (per la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia, per la facilità nella nutrizione e nell'allevamento, nella percezione del neonato come rispondente ai desiderata dell'immaginario materno), allora la valutazione oltrechè estetica assumerà una coloritura più profondamente emotivo-affettiva.
Possiamo dire che ci si percepisce soddisfacenti se l'altro è soddisfatto .
Last but not least, la qualifica di Bravo sembra implicare un giudizio di valore positivo circa l'operato di chi tuttavia potrebbe autonomamente decidere di disattendere le aspettative altrui, ovvero in questo caso genitoriali, trasgredendo.
Per esempio, un bambino che ubbidiente va a nanna quando è ora, che accetta di lavarsi i denti, che non fa troppi capricci, che comincia ad autonomizzarsi svestendosi e vestendosi da solo, che comincia a tenersi pulito, che va all'asilo volentieri accettando la separazione, è un bambino che sicuramente viene definito capace (bravo).
Implica una maturità ulteriore che si acquisisce quantopiù si è in grado di agire con discernimento avendo anche la facoltà di non osservare le regole, volontariamente.
Tale designazione sembra pertanto essere la successiva, in senso temporale, dopo le precedenti di bello e buono.
E' forse la terza che viene a svilupparsi come ultimo elemento fondativo di un giudizio che contiene apprezzamenti non più in prevalenza soltanto estetici o relativi alla facilità di allevamento, ma anche in qualche modo morali.
Nella pratica clinica non è infrequente imbattersi in anamnesi che raccontano di una primitiva difficoltà della madre a stabilire una relazione gioiosa e facile ("non mi piaceva il suo odore, la sua voce nel pianto era cacofonica, irritante, gracchiante; aveva lo sguardo vacuo e stuporoso con le rime palpebrali all'ingiù come un mongoloide...”).
Possiamo chiederci se sotto ad uno sguardo materno così preoccupato e deluso (come di fronte ad una creatura in carne ed ossa che, non riuscendo ad essere corrispondente nè dunque sufficientemente competitiva con quella fantasmatizzata nei nove mesi di gravidanza, appare simile ad una “bambola rotta”) non possa celarsi uno specchio pericolosamente distorcente, capace di segnare più o meno indelebilmente la futura immagine di sè che il bambino, lentamente e non senza difficoltà, va strutturando.
Un'eventuale inaccettazione iniziale cosiccome ogni altra difficoltà nella relazione madre-bambino che rendesse difficile riconoscere bellezza, bontà e bravura, potrebbe dunque rappresentare una sorta di imprinting negativo e potrebbe rendere difficile, quando non inficiare, la formazione d'una immagine di sè positiva ed un corretto sviluppo dell'autostima.
Quando dai due anni di età il bambino sarà capace di riconoscersi allo specchio ("il bambino nello specchio sono io "), potrebbe correre il rischio di sovrapporre a ciò che i suoi stessi occhi vedono (l'immagine oggettiva nello specchio ), l'immagine riflessa di se stesso percepita nello sguardo materno e, da qui in avanti, anche paterno.
Non è difficile comprendere, alla luce di quanto fin qui detto, come mai i bimbi intorno ai tre anni di età, abbiano paura del pagliaccio e, di fronte a questo, anzichè ridere, càpiti sovente che si mettano a piangere. La loro attitudine identificatoria è così spiccata da indurli a vedersi rappresentati nella goffaggine e nel grottesco del clown come in una superficie riflettente che li delinei, canzonandoli, così come essi si percepiscono: immaturi e deficitari , tratteggiati impietosamente in tutte le loro proprie tipiche debolezze, sproporzioni ed imperizie. A questa età non è facile riderne perchè non è facile prenderne le distanze.
Ai fini di un corretto sviluppo dell'immagine di sè è altresì importante, come abbiamo detto, potersi
meritare l'appellativo di Buono.
Questo segnale (non più intelleggibile solo nella qualità dello sguardo) è inoltre il primo che viene espresso verbalmente in maniera esplicita, ed è quello che ci dice che l'Altro è soddisfatto della nostra condotta intesa come possibilità di muoverci sempre più speditamente verso l'autonomia.
Se chi sta accanto al bambino si dimostra appagato dalla sua presenza e soddisfatto, oltrechè delle sue qualità fisiche e psicologico-affettivo-relazionali anche delle sue prime conquiste, allora indurrà facilmente il bambino a non nutrire nessuna paura, conscia od inconscia, che l'Altro lo possa rifiutare fino ad allontanarsi da lui.
E il bambino non avrà alcun motivo di deludere e perciò di temere, come conseguenza, la solitudine o l'abbandono.
Avrà trovato il sostegno adeguato (e adeguato vuol dire benevolo, tanto da rimandargli un'immagine di sè positiva) per saggiare sempre più e sempre meglio la possibilità di camminare nel mondo sulle proprie gambe, muovendosi da protagonista verso gli altri, verso le situazioni e verso le occasioni sorretto da una sana aggressività, e dunque sempre più consapevole e orgoglioso della propria acquisita autonomia.
Accettato dall'Altro, accetterà se stesso.
Il proverbiale monito: "ama il prossimo tuo come ami te stesso" sembra voler implicare il prioritario "ama (prima) te stesso se vuoi amare il prossimo tuo".
Dai due anni, dopo il passaggio della fase del riconoscimento allo specchio, il bambino entra dunque in quell'altra lunga, delicata e cruciale, della separazione-individuazione che lo vedrà impegnato a rescindere, per quanto metaforicamente, il cordone ombelicale, fino a godere di una rappresentazione di sè abbastanza solida da consentirgli un sempre più libero movimento.
Da quest'età in avanti, per sapere chi è e come procedere, avrà bisogno dello sguardo non più soltanto materno bensì, più genericamente, altrui (di quello paterno, di quello amicale, di quello di ogni Altro-che-conti, ed anche di quello completamente estraneo).
La percezione del "come si è " risulta infatti relativa al "come ci vedono gli altri" ma anche e soprattutto, da un certo momento in avanti, al "come noi vediamo gli altri in relazione a noi stessi grazie ai continui feedback e a quell'immagine remota di noi stessi che abbiamo potuto riconoscere nello specchio riflettente dello sguardo genitoriale".
Sapremo di essere relativamente alti o bassi, per es., se ci confronteremo con Watussi e Pigmei e non solo con gli uni o con gli altri!
Il processo di individuazione è, per così dire, perennemente in divenire e continuamente reciproco.
Ma se nello sguardo genitoriale avessimo ravvisato l'impressione di essere troppo bassi, non basterebbe una statura relativamente alta a convincerci di appartenere verosimilmente alla razza watussa.
Da quando il bambino intraprende la strada che conduce alla conquista della propria identità, potrebbe scoraggiarsi in mille occasioni, potrebbe diffidare della saldezza delle proprie gambe, potrebbe aver paura di inciampare o valutare male le distanze e “la misura” nei propri tentativi di rendersi indipendente.
Conoscere se stessi, come diceva Talete, costituisce per l'uomo l'impresa più ardua.
Il bambino ha pertanto bisogno di essere sostenuto e incoraggiato, ha bisogno che gli venga riconosciuto di essere un soggetto apprezzatamente attivo (e non più passivo come un'oloturia, una sorta di tubo digerente tutto riflessi e risposte semplici a stimoli primari), ha bisogno che i genitori gli riservino espressioni di manifesta approvazione e piacere quando afferma se stesso in modo positivo .
Ciò che è essenziale è che le esperienze dell'approvazione materna e paterna superino di granlunga quelle della disapprovazione.
Se arriverà a sentirsi buono, dopo che bello, gli sarà più facile sentirsi anche bravo.
La partecipazione attiva dei genitori è necessaria perchè, all'inizio, l'identità del bambino si forma esclusivamente in relazione ad essi; la sua identità potrà essere positiva soltanto se è in armonia con l'atteggiamento dei genitori verso di lui. Se il loro atteggiamento è in parte negativo o ambivalente, la sua identità potrà risultarne frammentata o distorta.
L'approvazione dei genitori lo porta a viversi come un individuo riconoscibile, diverso da tutti gli altri, e diventa così l'incentivo al formarsi della sua personalità individuale .
Ha bisogno altresì di essere riconosciuto meritevole di un giudizio sulla sua condotta (prototipo del giudizio morale) con un : "Bravo!" che lo rassicuri circa la conquista del merito.
Ricordo qui che la soddisfazione è sempre relativa ad uno sforzo, talchè ad ogni fatica corrisponderà sempre la conquista della soddisfazione di sè, ovvero della propria identità positiva.
Lo sforzo cosiccome la fatica (che implicano l'utilizzo della forza) permette il raggiungimento di un equilibrio interiore nel continuo adattamento alle esigenze degli altri laddove queste possano conciliarsi con le proprie; permette dunque la consapevolezza di detenere una forza.
Il premio che viene raggiunto mediante lo sforzo, consente l'ottenimento della soddisfazione (satis-facere ovvero fare abbastanza) nella consapevolezza di aver fatto al meglio delle proprie possibilità e nella certezza di essere nelle condizioni di meritare un plauso.
Qualunque difficoltà nell'acquisizione di un'immagine di sé come Bello renderà l'identità carente e in qualche modo tarata, rallenterà o impedirà la formazione di una corretta immagine del sè corporeo .
Qualunque difficoltà a percepirsi come Buono, incoraggerà comportamenti regressivi e di ripiegamento su se stesso con una grave difficoltà nello sviluppo dell'amore di sè , di quell'amore che rimane la fonte inesauribile del desiderio di costruirsi una personalità individuale, unica e irripetibile, il più possibile aderente alla propria natura.
Infine, la difficoltà o l'incapacità di meritarsi le lodi espresse mediante l'appellativo” Bravo!” non farà altro che suscitare un pericoloso e paralizzante senso di inadeguatezza o colpa che alimenterebbe le paure abbandoniche trattenendolo dallo sperimentare la necessaria autonomia e inducendolo a reagire negativamente verso gli altri ma anche verso di sè.
Sentirsi non abbastanza Bello potrebbe corrispondere al rischio di sviluppare complessualità o problematiche varie che hanno a che vedere con un'immagine del corpo disarmonica o dismorfofobica.
Sentirsi non abbastanza Buono e Bravo equivale a percepirsi come indegno di essere amato in quanto "oscuramente colpevole". Eventuali vissuti di inadeguatezza e disistima rischierebbero di provocare, per esempio, una tendenza ad assumere più facilmente la psicologia della vittima, del succube, del dominato o del tendenzialmente abulico, torpido e depresso quando non orientato a provocare il male secondo un circolo vizioso di insoddisfazione- dispiacere (antisociale).
Sentirsi infine non abbastanza Bravo, potrebbe incoraggiare una tendenza al perfezionismo come supercompensazione. Potrebbe indurre la costituzione di un Falso-sè o lo sviluppo di una personalità dominante, ma potrebbe anche gettare solide basi per lo sviluppo di un disturbo narcisistico della personalità.
Quando si parli di educazione intesa come arte dell'allevamento che si prefigge di cavar fuori (ex-ducere) il meglio da ogni individuo, conviene ricordare il concetto greco-antico del Kalokagathòs (crasi di Kalòs kai Agathòs). Già in esso era contenuto, secondo la cultura ellenica, il concetto di fusione tra etica ed estetica per cui al bello si accompagnerebbe sempre il buono (inteso anche come abile, onesto, coraggioso) e viceversa, in un'inscindibile coesistenza. In qualche modo vi era compresa anche l'Aretè ( virtù intesa come coraggio di vivere al di là delle avversità dominando il dolore attraverso la conoscenza ed il governo di sè secondo misura).
Perciò, a ben guardare, nulla di nuovo ci sarebbe nell'invocare una maggior attenzione nel promuovere adeguatamente l'utilizzo psicopedagogico di quelle "tre B" - Bello Buono Bravo - come qualità di cui è bene tener conto se si vuole coltivare lo sviluppo di future soddisfacenti relazioni oggettuali d'amore e di relazione.
Dopotutto, per un animale sociale come l'uomo, tali relazioni sono condicio sine qua non di vitale importanza, e non possono prescindere dalla conquista di una positiva identità e di un armonico sviluppo di una personalità sana.
Per trovare quindi il coraggio e la necessaria forza di reggere un disilluso esame di realtà, conviene affacciarsi alla vita con un'immagine di sè complessivamente positiva.
E' bene che ogni uomo abbia fin dall'inizio una solida base di amore e di stima di se stesso grazie alla quale possa sentirsi sufficientemente competitivo guardando agli altri, nella temperata saggezza che l'umano dolore ingenerato dalla consapevolezza di non poter evitare la propria sorte mortale, si può reggere ed entro certi limiti dominare.
Ci penserà poi la vita a renderci edotti della ineluttabilità della legge di natura.
Siamo mortali e il limite che la Natura ci pone è invalicabile come ben ci ricorda il mito di Icaro.
Questi, pur essendo stato messo nell'avviso da suo padre che lo esortava a rimanere "coi piedi per terra", volle osare ascendere fino a dove abitano gli Dei secondo un'impresa per definizione impossibile ad un umano, e venne inevitabilmente punito per la sua tracotanza.
La vita, come ben sapevano i Greci antichi, contempla un aspetto inesorabilmente tragico: è ricca di aporìe e contempla finitezza e dolore, costitutivi dell'esistenza. Perciò, se a nulla vale trascorrere la vita rimirando se stessi come Narciso nella presunzione di essere migliori degli Altri, se è fuorviante identificarsi nel Brutto Anatroccolo pur essendo nato cigno, se è pericoloso e vano sentirsi simili agli Dei dunque superiori a tutti gli altri mortali come accadde ad Icaro, per vivere una vita di soddisfazioni degna di essere vissuta sarà necessario accogliere per intero la condizione umana che prevede di tenere in gran conto lo sguardo dell'Altro come specchio parlante.
Se tale specchio fosse perennemente univoco come era perlopiù quello della regina Grimilde nella fiaba di Biancaneve ("la più bella sei tu, mia Regina, dal bosco alla collina, dal mare alla città sei regina di beltà!) non ci consentirebbe di effettuare i continui aggiustamenti di volta in volta migliorativi dell'immagine di sè e ci condannerebbe ad un'immagine primigenia (positiva o negativa che sia) qual'è quella che si sviluppa nella primissima infanzia derivante esclusivamente dal primo- sguardo-che-conta: lo sguardo genitoriale.